PAROLE E IGNORANZA LA PANDEMIA ACUISCE LA VIOLENZA VERBALE
di PAOLO CORTICELLI
Negli ultimi tempi ricorre con maggiore frequenza sui mass media un argomento: c’è una crescente, diffusa riscoperta della solidarietà, con la pandemia, oppure homo hominis lupus, per citare il motto di Thomas Hobbes, filosofo inglese vissuto fra il XVI e il XVII secolo? Secondo il pensatore britannico, la natura umana è fondamentalmente egoistica, e a determinare le azioni dell’uomo sono soltanto l’istinto di sopravvivenza e di sopraffazione. Egli nega che l’uomo possa sentirsi spinto ad avvicinarsi al suo simile in virtù di un amore naturale. Un giudizio severo, senza remissioni.
Durante questa pandemia abbiamo assistito a molteplici gesti che non lasciano dubbi: spirito di abnegazione, sacrificio – anche fisico -, grande attenzione nell’individuare un percorso terapeutico contro il virus hanno caratterizzato spesso le azioni non solo del personale sanitario ma anche di alcuni pubblici amministratori, così come di gente comune che si è attivata per prestare soccorso, assistere, recare conforto a chi è stato in difficoltà.
Ma c’è un aspetto che continua a segnalare una difformità di comportamenti rispetto al gesto solidale, e tutto ha inizio con il linguaggio: greve, offensivo, violento. Nella globalizzazione dei mezzi di informazione, c’è il rischio tutt’altro latente, anzi, ormai sempre più consolidato dell’annientamento dell’autocoscienza di sé: siamo ormai rivolti in modo esasperato verso l’esotico, con un consumo di immagini e notizie – o presunte tali – sempre più affrettato. Noi non tendiamo a soddisfare una corretta esigenza informativa, bensì mostriamo una voracità cognitiva che, illusoriamente, rincorre la velocità delle proposte.
C’è una violenta messa in atto di modelli, o presunti tali, di libertà e di successo. Prevale l’estetizzazione superficiale, l’ostentazione.
Applichiamo lo zapping anche al nostro pensiero: tutto deve essere fatto in fretta. Applichiamo lo zapping nel dialogo con i nostri figli e lasciamo loro messaggi caratterizzati da sublime superficialità: però si è detto molto. Nel lavoro il dialogo è in funzione della gerarchia. Ci sono i progetti qualità, con banali riferimenti alla sostenibilità – che mette al centro di ogni percorso personale e professionale proprio l’uomo – e alla comunicazione. Nei fatti prevale il taylorismo, ovvero la razionalizzazione del ciclo produttivo elaborata da Frederic Taylor alla fine del XIX secolo: il termine indica tutti gli aspetti di un lavoro, sia manuale sia impiegatizio, organizzato secondo criteri ripetitivi, parcellizzati e standardizzati.
Linguaggio e cultura
L’elemento che collega la cultura al dinamismo della vita sociale è la lingua. Il linguaggio che utilizziamo oggi è il riflesso dell’impoverimento culturale nel quale siamo progressivamente sprofondati: l’ignoranza di cui ci pasciamo quotidianamente – notizie false sui social network, trasmissioni televisive in cui, oltre a una ripetitività di partecipazione degli “ospiti”, si aggiunge talora una fastidiosa sagra dell’insulto, delle voci sempre più alte, a sovrapporsi, e l’acuta e vacua capacità espressiva riverbera spesso la povertà di contenuti, che scaturisce da un’esibizione costante di incompetenza, esibita come “nuovo sapere”, mentre un percorso realmente culturale richiederebbe ben altro.
“Noi intendiamo la cultura come memoria non ereditaria di una collettività che esprime un sistema determinato di divieti e prescrizioni”: la definizione del semiologo Jurij Lotman (Semiotica e cultura, Ricciardi, 1975, pagina 66) merita qualche considerazione. Prima di tutto l’aspetto relativo alla non ereditarietà del patrimonio culturale. In altri termini, ciò che sappiamo l’abbiamo conquistato in una personale – l’impegno è sempre individuale – ricerca del sapere. Gli esiti sono differenti, talora incompatibili (un mussulmano e un cattolico, per stare a un esempio di stretta attualità). La cultura non è quindi soltanto una “memoria della collettività” ma è un palese arricchimento della persona. Diviene sociale nel momento stesso in cui l’individuo si pone in confronto all’altro da sé e procede a uno scambio/verifica di informazioni.
Il linguaggio che usiamo è il riflesso dell’impoverimento culturale nel quale siamo progressivamente sprofondati a partire dai primi anni Settanta. Oggi, nel terzo millennio, abbiamo amplificato a dismisura questo depauperamento con i social network, palestra dove l’ostentazione dello sproloquio, dell’insulto, della maleducazione – termine caduto in disuso, ahinoi! – è abnorme, priva di efficaci controlli.
Hannah Arendt, filosofa tedesca, ripercorre nel suo libro “La banalità del male” (Feltrinelli, 2019) il processo che si tenne in Israele a partire dal 1961 e che portò alla condanna a morte di Adolf Eichmannn – sentenza eseguita il 31 maggio 1962 – per aver commesso, “in concorso con altri”, crimini contro il popolo ebraico, crimini contro l’umanità e crimini di guerra, nel corso della seconda guerra mondiale. Hannah Arendt si sofferma su un aspetto che susciterà diverse reazioni fra i commentatori: ciò che la filosofa vuole sottolineare è il fatto che Eichmann e altri esponenti nazisti erano persone mediocri, modesti culturalmente, comuni e banali, come il male che hanno rappresentato.
L’ultimo fatto di cronaca è sconvolgente e paradigmatico, poiché purtroppo è l’ultimo, ferale evento di una lunga serie. Siamo di fronte allo sterminio, in ambito familiare: in una coppia che sta per separarsi, il padre uccide i due figli, gemelli, e si uccide. Abitavano a Gessate, in provincia di Milano, il padre aveva portato i figli in Valsassina, dove avevano una casa. E nella sua mente era stato tutto programmato. Che tipo era il pluriomicida? Una persona normale, precisa, attenta all’educazione dei figli, secondo le testimonianze… Poi ecco l’ipotesi della separazione e qualcosa si incrina nella mente, fino a giungere a un gesto inenarrabile, atroce. Il male si palesa in un contesto di normalità ormai illusoria.
Spesso sono del tutto persone comuni coloro che commettono femminicidi, che investono e uccidono chi sta attraversando la strada, senza fermarsi per prestare soccorso, che addirittura adeguano e trasformano strutture criminali in realtà che assomigliano molto più a holding finanziarie che non a bande pronte a uccidere seminando di morti le città dopo sparatorie, definite curiosamente “regolamenti di conti”.
Figuriamoci se un palcoscenico come quello offerto dai social network non risveglia istinti primordiali addirittura in ambito planetario, con le manifestazioni troppo spesso disdicevoli se non turpi cui abbiamo fatto cenno prima.
Per non parlare di quanto accade nel Parlamento italiano, talora trasformato in un saloon del Far West: esibizioni di cartelli, di forche (sic!), di manette… con improperi scambiati senza alcun ritegno, con una totale mancanza di rispetto delle istituzioni rappresentate e degli elettori, molti dei quali per altro sono troppo distratti, sul web, a scambiarsi insulsaggini frammiste a reiterate violenze verbali.
Guerra santa e anoressia del pensiero
Nella “guerra santa contro gli infedeli, il jihad, troviamo una totale radicalizzazione dell’annientamento dell’altro da sé in nome di Dio, il quale ha la propria legge, la shari’a, che deve essere seguita e applicata senza obiezioni né esitazioni. Roberto Calasso, saggista e editore, nel suo “L’innominabile attuale” (Adelphi, 2017), si sofferma proprio sui termini che caratterizzano un percorso sanguinario perpetrato da coloro che devono combattere gli infedeli. Prima di tutto, nell’Islam più radicale “il paradiso è riservato ai martiri del jihad, ed è colmo di piaceri, come si legge nel Corano”. Per raggiungere il paradiso è necessario il martirio, il sacrificio, individuale o di più soggetti. Fondamentale seminare morte e terrore. “Per il terrorismo islamico – scrive Calasso -, una chiesa copta o un grande magazzino scandinavo sono bersagli altrettanto appropriati. Occorre solo manifestare il rigetto dell’Occidente in tutta la sua estensione, dalla cristianità alla secolarità… Occorre concentrare l’odio su un punto, se possibile fitto di vita. Ma quel risentimento non è nuovo. Sussisteva già cinquanta anni fa. Perché soltanto ora assume queste forme? È uno dei tanti risultati della disintermediazione, direbbe subito un teorico del web. E del fatto che il mondo tende a diventare istantaneo e simultaneo. Chi si uccide uccidendo è un modello supremo di disintermediazione” (op. cit. pagine 20 e 21).
Le parole vestono il nostro pensiero e tanto più sono volgari e violente, tanto più la nostra mente ne assumerà la forma. Ma dobbiamo insistere nel cercare uno sguardo alto, di profondità, per allontanarci da quella superficialità che avvilisce la nostra capacità critica. Nel libro di Ivano Dionigi – presidente della Pontificia accademia di latinità e direttore del Centro studi “La permanenza del classico” dell’Università di Bologna – dal titolo “Parole che allungano la vita. Pensieri per il nostro tempo” (Raffaello Cortina Editore, 2020), nell’introduzione troviamo un monito del cardinale Gianfranco Ravasi: “L’anoressia del pensiero contemporaneo – scrive Ravasi – paradossalmente produce un’ipertrofia della chiacchiera che è la parola degenerata. Bisogna ritrovare il rigore della ragione, esercitare con impegno l’intus legere, che è la base etimologica del termine intelligere, cioè l’approfondimento che esorcizza la superficialità e la banalità” (pag. 12). E l’opera di Dionigi ci prende per mano, con uno stile semplice e diretto, per farci percorrere un viaggio in cui incontriamo parole tratte dai classici come dall’attualità, dalla filosofia come dalla politica per riscoprirne significato e valore. Ad esse è affidata la non impossibile riscoperta dell’homo sapiens. È un auspicio. In attesa di conferme.


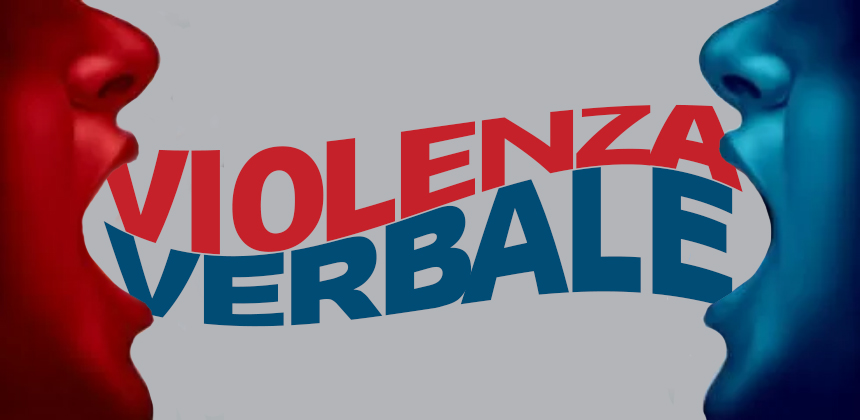



Commenti